Pruriti Scientifici: linguaggio oggettivo e soggettivo – by Ilia

“Quella che sul piano soggettivo è la felicità, sul piano oggettivo
coincide con la realizzazione della propria essenza.”
Socrate (469 a.C. – 399 a.C.)
Ci siamo lasciati l’ultima volta parlando di dualismo, di microcosmo e macrocosmo, accennando a diversi temi da sviluppare in futuro. Proviamo adesso a riannodare le fila del discorso partendo da un argomento un po’ diverso.
Cercherò di indagare, in base alla mia esperienza personale, la natura del linguaggio matematico, che viene utilizzato per esprimere concetti di carattere tecnico-scientifico, confrontandolo col linguaggio comune che normalmente utilizziamo per comunicare.
Mi sono trovato diverse volte ad interrogarmi sul perché non sia semplice comunicare e facilmente si incorra in incomprensioni e fraintendimenti, quando si parla di qualcosa che riguarda la propria esperienza di vita, le proprie emozioni che, per loro natura, non sono codificabili in simboli matematici, in categorie precise.
Il linguaggio matematico è un linguaggio simbolico che ha lo scopo, a partire dall’osservazione della natura, di descriverne il comportamento secondo un processo logico di causa ed effetto, in cui gli elementi osservati vengono messi in relazione. Esso si basa su due concetti fondamentali: la teoria degli insiemi e la logica delle proposizioni.
La teoria degli insiemi ci assicura che gli oggetti di cui parliamo sono delle cose ben definite: gli insiemi sono caratterizzati dal fatto che possiamo stabilire con esattezza se un elemento sia o meno contenuto all’interno di un determinato insieme. Per esempio la mela appartiene all’insieme dei frutti, il cane all’insieme degli animali. Lo stesso principio vale per le proposizioni: le frasi che si usano in matematica non devono essere ambigue, ovvero bisogna saper dire esattamente se una frase è vera o falsa.
Le caratteristiche del linguaggio matematico (numeri, equazioni, figure geometriche…) sono assimilabili anche al linguaggio musicale, a quello informatico e a tutti i linguaggi tecnici e simbolici, dove le cose di cui si parla hanno una definizione ben precisa, di carattere oggettivo. Anche un linguaggio filosofico rigoroso, come quello di alcuni testi di filosofia orientale, può essere considerato tale.
Secondo la Tradizione infatti, molti testi come ad esempio i Veda, la Bhagavadgita, la Cabala, parlano di principi oggettivi legati alla vita e all’universo, attraverso la narrazione di storie, allegorie e leggende. Utilizzando un codice cifrato, come si faceva durante la seconda guerra mondiale per scambiarsi informazioni riservate, la conoscenza viene comunicata a chi è stato “iniziato ai misteri”, ai simbolismi e ai principi necessari per comprendere il funzionamento del microcosmo e del macrocosmo. E poiché queste informazioni devono passare inosservate a chi non possieda la preparazione interiore adeguata, il linguaggio utilizzato ricorre ad immagini comuni, dando così la parvenza ai non iniziati di comprenderne comunque il significato, che in realtà rimane nascosto ai più.
Il linguaggio comune, sia orale che scritto, serve per raccontare eventi, sensazioni ed emozioni. Esso si basa sull’esperienza e la sensibilità di ogni singolo individuo e la sua natura è dunque intrinsecamente soggettiva.
Per esempio quando parliamo di un frutto, di una casa, di un cibo, associamo a questi elementi qualità che provengono direttamente dalla nostra esperienza e dal nostro sentire, formatisi all’interno di una ben determinata cultura, in un particolare periodo storico. Non a caso ogni Stato ha una sua lingua, e anche all’interno di uno Stato si incontrano dialetti differenti che impedirebbero di fatto la comunicazione se non esistesse una lingua nazionale come punto d’incontro.
La seguente esperienza è alquanto illuminante a riguardo. Alcuni colleghi cinesi e giapponesi, le cui lingue si basano su ideogrammi e non sulla fonetica, trasferitisi in Occidente, mi hanno parlato del loro periodo iniziale qui da noi, come di uno shock culturale alquanto destabilizzante: integrarsi in un mondo così diverso dal loro richiede del tempo, per lo studio della lingua del luogo e la frequentazione delle persone.
Riepilogando dunque, da una parte abbiamo il linguaggio matematico, uguale su tutto il pianeta, indipendentemente dal luogo e dalla cultura, per sua natura oggettivo, caratterizzato da un certo livello di astrazione e assolutamente privo di emotività. Dall’altra il linguaggio comune, diverso a seconda del luogo e della cultura di provenienza, per sua natura intrinsecamente soggettivo e ricco di sfumature emotive.
Nella mia esperienza d’insegnamento di materie scientifiche (matematica e fisica) ho potuto osservare molte volte una forma di ritrosia nei confronti della loro comprensione. Un vero blocco emotivo che, in maniera del tutto preconcetta, porta a considerare tali discipline come difficili, noiose e, fondamentalmente poco utili nella vita pratica. L’assenza di emotività del linguaggio matematico è a mio parere uno dei motivi di questa difficoltà. Più che di una reale incapacità di comprensione, si tratta di una forma di rifiuto, che è compito di un buon insegnate saper aggirare per permettere all’allievo di aprirsi.
L’essere umano è alla ricerca della felicità, che può essere raggiunta in modo stabile, solo attraverso la realizzazione di sé.
Lo studio del linguaggio fa parte di quel processo più ampio di Conoscenza che permette all’essere umano di evolvere, passando da una percezione puramente soggettiva di se stesso e del mondo, ad una visione più oggettiva che coniuga libertà e responsabilità.
Risulta dunque sempre attuale l’imperativo di Socrate:
Uomo, conosci te stesso.

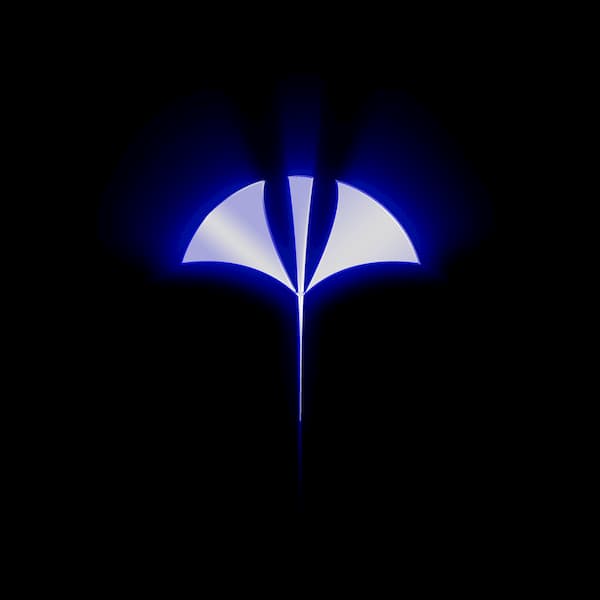



Ciao Ilia, ben tornato! Scrivi che in alcune persone l’assenza di emotività del linguaggio matematico produce un vero blocco emotivo… Non ci avevo mai pensato ma… in effetti mi sa che tu abbia proprio ragione!!!
Grazie per questo bel post!!! :bye:
Ciao valeria, grazie del tuo commento. Effettivamente mi sono preso una lunga pausa a causa di tante altre cose che stanno succedendo nella mia vita, e scrivere questi post, almeno per me non è affatto semplice, mi prende diverse ore. Sono contento se quello che scrivo può essere d’aiuto o di spunto di riflessione.
Un caro saluto. 🙂
Assolutamente si, lo è quindi… NON MOLLARE!!!